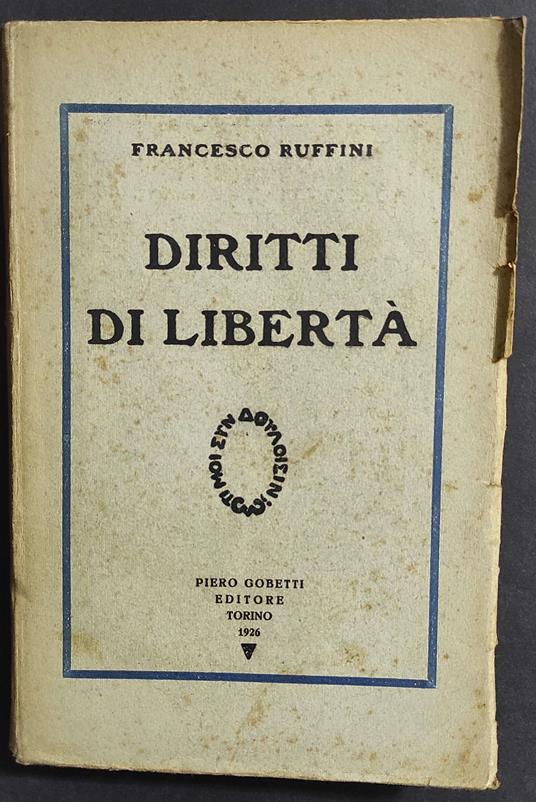Raoul Pupo è uno storico italiano, professore di Storia contemporanea all’Università di Trieste, tra i massimi conoscitori dell’Esodo giuliano-dalmata e dei massacri delle foibe.
Quali sono secondo Lei le principali motivazioni per cui il giorno del Ricordo è ancora così divisivo?
Una sola: la politicizzazione. La legge istitutiva è stata a suo tempo approvata a larghissima maggioranza dal Parlamento con un gesto denso di significato, perché ha voluto dire che le vittime delle tragedie del confine orientale non erano i caduti di una parte della nazione (fascisti, nazionalisti) ma di tutta la nazione. Poi, nel corso del tempo, ci sono stati vari tentativi di forzare questa grande e fondamentale acquisizione: abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo a vere e proprie campagne di “colonizzazione” del giorno del Ricordo da parte della destra italiana ed in particolare di alcune forze politiche, anche attraverso la diffusione di interpretazioni, dati e formule proprie della cultura nazionalista e che mai hanno avuto cittadinanza nella comunità degli storici. Contemporaneamente, alcuni nuclei di irriducibili zelatori della repubblica federativa jugoslava hanno continuato a riproporre invece quelle che erano state le tesi prima delle propaganda e poi della storiografia di regime della Jugoslavia comunista: le stragi delle foibe sono solo un’invenzione della propaganda fascista; c’è stata solo la giusta punizione di qualche criminale; tutti quelli che sono stati colpiti nel 1943 e nel 1945 dovevano essere colpevoli, altrimenti non li avrebbero presi; l’esodo è stata un’emigrazione verso il benessere capitalista oppure il frutto di un inganno del governo italiano, e così via. Beninteso, si tratta di frange assai circoscritte, collocate all’estrema sinistra, ma molto attive sul web.
Vero è, che talvolta i loro giudizi vengono espressi in modi anche assai irriguardosi per le memorie dolorose e questo ha suscitato comprensibile, grave disappunto fra parenti ed eredi delle vittime. Da qualche anno a questa parte però, ciò ha innescato una campagna allarmista da parte di alcune associazioni di profughi e delle forze politiche di destra, che ha finito per ingigantire un fenomeno in realtà marginale. Ma non basta. Sempre dalla medesima parte, si è diffusa nell’uso pubblico l’abitudine di tacciare di “negazionismo”, o almeno del suo cugino “riduzionismo”, qualsiasi intervento che metta in discussione la rispolverata vulgata nazionalista.
Rispunta dunque la logica maledetta dell’intolleranza, che tanto sembra piacere di questi tempi, specie a chi privilegia le logiche della pancia rispetto a quelle del cervello. Fortunatamente, tale deriva è stata contrastata da molte altre iniziative ben più attente al rigore storico ed interessate invece a costruire percorsi di pacificazione. È questo il caso, ad esempio, delle attività promosse dalla rete degli Istituti per la storia della resistenza, che ben prima dell’istituzione della giornata memoriale avevano mostrato grande sensibilità per la storia del confine orientale. Ma ciò che più conta, vi sono stati alcuni interventi riequilibratori dei vertici istituzionali, cioè dei presidenti della Repubblica, che si sono spesi oltre ogni speranza in una logica di riconciliazione fra i popoli e le loro memorie. Speriamo che vengano ascoltati.
In Italia si parla spesso di infoibati italiani trascurando il fatto che il fenomeno ha coinvolto anche sloveni e croati. Quali sono le motivazioni che portano a trascurare questi aspetti?
Principalmente la poca conoscenza, spesso alimentata anche dai media, che preferiscono le semplificazioni rispetto alla delineazione di un quadro più articolato: questo accade frequentemente, ma è più grave quando si parla di una regione di frontiera, dove si sovrappongono lingue, culture politiche, aspirazioni contrastanti, memorie divise, ma anche logiche diverse che governano gli accadimenti rispetto a quel che è avvenuto in Italia. Un esempio da manuale è quello delle stragi del 1945 – cioè le foibe – che rappresentano la coda più occidentale di un’enorme ondata di violenza politica che ha riguardato tutti i territori liberati dai tedeschi nel medesimo periodo da parte delle truppe jugoslave, e che ha condotto all’eliminazione fisica di tutti coloro che si erano compromessi con il potere tedesco (e prima italiano) o che comunque erano considerati pericolosamente ostili all’instaurazione del nuovo regime comunista. Stiamo parlando di molte decine di migliaia di persone, in un gigantesco bagno di sangue. Ovviamente, nei territori popolati da italiani le vittime furono quasi solo italiane, perché erano gli italiani ad essere legati al potere che si voleva distruggere ed anche perché fra loro – antifascisti non comunisti compresi – era diffusa la contrarietà all’annessione alla Jugoslavia di Tito.
Guardando quindi il fenomeno “dalla parte giusta”, da est verso ovest, in una prospettiva jugoslava piuttosto che italiana, questo diventa molto più comprensibile, il che non vuol dire affatto giustificabile, perché rientra sempre fra i casi di criminalità politica di massa.
Quali sono le caratteristiche che rendono particolare la foiba di Basovizza?
In primo luogo, non è una foiba, cioè un abisso naturale, ma un pozzo minerario; però questo è largamente irrilevante. In secondo luogo, si tratta della cavità in cui è stato probabilmente occultato il maggior numero di salme di italiani uccisi in entrambe le stagioni della violenza di massa, quella dell’autunno 1943 e quella della primavera 1945: l’ordine di grandezza dovrebbe essere di alcune centinaia di vittime. Peraltro – altro connotato essenziale – mentre le testimonianze sono cospicue, manca il corpo del delitto, perché i recuperi non sono mai stati possibili per ragioni tecniche. Comprensibilmente, ciò ha innescato per decenni polemiche a non finire, ancora non del tutto sopite.
A suscitarle ha poderosamente contribuito la geniale trovata comunicativa di un giornalista dell’epoca che, non sapendo che cosa scrivere, ipotizzò che nella cubatura di detriti che ingombra il pozzo potessero esser stati ammucchiati fino a 1.500 cadaveri. Rapidamente, nell’uso pubblico e politico, tale ipotesi si è trasformata nei 1.500 italiani infoibati a Basovizza, in alcuni casi poi lievitati per virtù propria fino a 2.000 0 2.500. È facile capire come tale disinvoltura abbia prestato il fianco a critiche feroci, che in molti casi si sono spinte oltre, cioè fino al punto di negare che qualcuno nella foiba sia stato effettivamente gettato.
Il cortocircuito fra storia e mito è stato poi alimentato dal fatto che, comunque siano andate le cose, il sito è divenuto il simbolo di tutte le violenze subite dagli italiani fra guerra e dopoguerra ed il luogo privilegiato delle cerimonie commemorative. A questo punto, il nodo è diventato gordiano, fino a che i presidenti delle repubbliche di Italia e Slovenia, nel luglio 2020, hanno deciso di tagliarlo con un gesto di pietà condivisa, che va oltre le memorie ed i giudizi storici.
Nel corso degli anni c’è stata molta confusione sul numero degli infoibati, secondo gli studi più recenti qual è il numero delle vittime?
Con certezza non si sa, perché lo stato delle fonti non lo consente. È possibile tuttavia farsi un’idea di quale sia l’ordine di grandezza complessivo delle vittime delle due ondate di violenza del 1943 e 1945, subito precisando che il termine “infoibati” rischia di depistare il lettore, perché molti degli uccisi trovarono la morte in altra maniera ed i loro corpi sono finiti chissà dove. Meglio quindi è parlare complessivamente degli “scomparsi”.
Per il 1943 tale ordine di grandezza è abbastanza facile da stabilire ed è di 500 vittime, concentrate nella provincia di Pola. Per il 1945 invece i calcoli sono complicatissimi. Ci aiuta una ricerca compiuta dall’Istat alla fine degli anni ’50, secondo la quale il numero delle vittime civili nelle sole province di Udine, Gorizia e Trieste ammonterebbe a 2.627. Ovviamente, le cifre finali possono ballare un po’ com’è inevitabile in questi casi, però è un buon inizio. A tale risultato – magari depurato da errori e doppioni – vanno sommati gli uccisi nelle province di Pola, Fiume e Zara. Per Fiume abbiamo una stima molto buona, frutto di un esemplare lavoro di collaborazione fra la Società di studi fiumani ed alcuni ricercatori croati, che fissa il totale dei caduti a circa 600. Nulla del genere, purtroppo, è stato fatto per l’Istria, ma per Pola e la parte meridionale della penisola una buona stima è di circa 800 persone, cui bisogna aggiungere gli scomparsi dal resto della provincia, comprese le zone interne a popolamento croato, dove pure vi furono delle vittime. Quanto a Zara, le violenze riguardarono solo l’aliquota residuale di popolazione rimasta in città dopo che la maggioranza era già sfollata in Italia a seguito dei bombardamenti aerei del 1943-44, che distrussero praticamente tutto il centro urbano. Le stime correnti parlano di più di 100 vittime.
Siamo arrivati dunque ad almeno 4.000 unità, alle quali vanno aggiunte le vittime militari. Qui però la situazione delle fonti è ancora peggiore, perché che la documentazione di cui disponiamo non distingue tra i vari flussi di prigionieri che si sono accavallati nel corso del tempo in mani jugoslave: quelli appunto fatti prigionieri nella Venezia Giulia a fine guerra; quelli – molto più numerosi – catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre e successivamente divenuti prigionieri dell’armata popolare; ed infine quelli internati in Germania dopo l’armistizio, liberatisi nella primavera del 1945 e che hanno avuto la pessima idea di attraversare la Jugoslavia per cercare di tornare in Italia, con l’unico risultato di venir nuovamente arrestati e costretti a “collaborare” con il loro lavoro alla ricostruzione di quello Stato che avevano precedentemente distrutto. Ipotizzare, sulla base delle denunce di scomparsa – peraltro probabilmente parziali e non sempre attendibili – che fra le migliaia di catturati nella primavera del 1945 parecchie centinaia non siano tornati sembra ragionevole, ma oltre è davvero difficile andare.
Complessivamente quindi a che fare con un ordine di grandezza di alcune migliaia di vittime, sembrerebbe fra le quattro e le cinque. Di più, è francamente improbabile, a meno di non conteggiare – come fa disinvoltamente qualche elenco – anche i caduti in combattimento italiani contro i partigiani, magari anche nella Dalmazia annessa dopo il 1941, ovvero di dar per certi tutti i presunti il che, fortunatamente per loro, non è vero. Di meno, è possibile, come esito di un’accurata ripulitura degli elenchi da errori e doppioni, ma probabilmente non di molto.
Molto spesso c’è lo stereotipo diffuso di definire gli esuli come fascisti, da dove nasce questo stereotipo?
In primo luogo, naturalmente, dal fascismo stesso, che durante in Ventennio ha fatto tutto quel che poteva per convincere i cittadini della Venezia Giulia che Italia e fascismo erano la stessa cosa. Purtroppo ci è riuscito piuttosto bene, nel senso che per i partigiani sloveni e croati dire italiani o dire fascisti era equivalente. La situazione non cambiò molto nel dopoguerra nei territori sotto controllo jugoslavo. Qui i vertici del partito comunista usavano il termine “fascista” con un significato assai largo, ad esempio come sinonimo di “legato al potere italiano”, oppure di “ostile al movimento di liberazione”, ovvero anche di “contrario all’annessione alla Jugoslavia” e “avverso alla costruzione del socialismo”. Ricadere in tale categoria per gli italiani era quindi piuttosto facile: è vero che ai livelli decisionali superiore si faceva distinzione fra gli “italiani onesti e buoni” e i ”residui del fascismo”, ma i quadri locali, di estrazione partigiana, tendevano in genere a semplificare.
Ora, ufficialmente la politica del governo jugoslavo, concordata con il partito comunista italiano, era quella della “fratellanza italo-slava”, che prevedeva il mantenimento in Istria ed a Fiume di una minoranza italiana, tutelata per legge, anche se drasticamente ridimensionate rispetto all’anteguerra. In concreto, la “fratellanza” non funzionò, per i suoi stessi limiti (si trattava di una politica di integrazione selettiva a condizioni particolarmente pesanti), per le sue difficoltà di applicazione da parte dei dirigenti locali che non ci credevano e, da ultimo, perché la crisi del Cominform spiazzò completamente i comunisti italiani, gli unici ad aver cercato di integrarsi nel sistema jugoslavo.
Ma nel 1946 e 1947, quando in Italia cominciarono ad arrivare le prime ondate di profughi, fra Tito e Stalin non era ancora scoppiato il gelo e dunque, per il PCI, chi fuggiva dalla Jugoslavia socialista non poteva che essere un anticomunista, cioè un fascista. Da ciò episodi anche clamorosi di ostilità nei confronti dei profughi e la diffusione dello stereotipo, duro a morire, negli ambienti della sinistra.
Come è cambiata la memoria delle foibe dopo l’istituzione della giornata del Ricordo? C’è stata una maggiore attenzione anche degli storici?
Le memorie di frontiera naturalmente sono sempre le medesime, soggettive, divise e certo non interscambiabili, ma fortunatamente si parla sempre meno della necessità di una “memoria condivisa”, che è una contraddizione in termini rispetto alla soggettività dei ricordi, e sempre più di riconoscimento delle varie memorie e di reciproco rispetto. Fra le diverse memorie, quella che sino agli anni ’90 del ‘900 era più a rischio, era quella dell’esodo e, più in generale, della stessa esistenza storica delle comunità italiane in Istria e a Fiume. Oggi invece questa memoria è stata salvata, ha suscitato l’attenzione di studiosi e media ed in alcuni casi è stata anche monumentalizzata.
Se invece parliamo della conoscenza storica diffusa nel Paese, allora questa è certo aumentata, vuoi per le celebrazioni ufficiali, vuoi e soprattutto per l’intensissima attività didattica sviluppata da numerosi soggetti, istituzionali e privati. È tuttora molto polarizzata sulle foibe – dramma dal grande impatto emotivo e facilmente comunicabile – meno sull’esodo, che pur rappresenta un fenomeno di gran lunga più significativo e, addirittura, periodizzante. Ancora una volta, si tratta di uno squilibrio legato all’uso politico ed alla funzione selettiva ed amplificatrice dei mezzi di comunicazione.
La “riscoperta” della storia del confine orientale ha riguardato anche la storiografia, dapprima semplicemente con una maggior attenzione ai prodotti di chi già si occupava, prevalentemente in sede locale, di quelle vicende, poi anche con nuove ricerche. Avviene qui il rovescio di quanto accade nell’uso pubblico: in quello prevale l’attenzione per le foibe, sul piano degli studi invece per l’esodo. È logico che sia così. Le stragi del 1943 e del 1945 sono state un’esperienza drammatica e traumatica, ma circoscritta e spiegabile con una certa facilità: le fonti decisive sono note da un trentennio e per le indagini si tratta di una pista ormai fredda. L’esodo invece è stato un fenomeno assai più ampio ed articolato, snodatosi per più di un decennio e che ha coinvolto un’intera società locale ben articolata. Si tratta quindi di un campo di ricerca assai vasto non solo per la storia politica, ma anche per quella sociale e per l’antropologia, sia che si studi la fase distruttiva, cioè lo scompaginamento e sradicamento delle comunità italiane dalle loro sedi storiche d’insediamento, sia che si affrontino invece i temi della profuganza, dell’accoglienza e della ricostruzione delle esistenze individuali e comunitarie nella diaspora.
Fra le novità infine dell’ultimo ventennio, va segnalata la funzione importante di alcuni storici di frontiera di nuova generazione, talvolta residenti in Croazia, talaltra in Italia, ma portatori di doppia cittadinanza, di competenze linguistiche e di conoscenze storiografiche che consentono loro di muoversi agevolmente nei diversi contesti. È a loro, ad esempio, che dobbiamo gli studi più innovativi sulla realtà istriana del secondo dopoguerra, condotti sulle fonti ex jugoslave, che siamo ora finalmente in grado di incrociare con quelle italiane, in modo da consentire una visione a tutto tondo di vicende obiettivamente assai complesse.